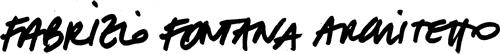quid tum
Orazione funebre per Manfredo Tafuri pronunciata da Massimo Cacciari il 25 febbraio 1994 nel cortile dei Tolentini allo IUAV_Venezia
Credo tutti noi sappiamo che cosa ci direbbe Manfredo in questo momento. Ci chiederebbe perché piangiamo – ci chiederebbe se non sappiamo che il nome del fiume che ci strappa via è Vita, e che “eius ripa mors”. E poi aggiungerebbe – e chi lo ha ascoltato saprebbe la fonte delle sue citazioni – che il fiume omologa, non uguaglia, non deforma i lineamenti di alcuno.
Nel fiume che è Vita trascorrono quelli che vengono sbattuti qua e là, quelli che si aggrappano ad otri gonfi e vani, quelli che nuotano disperati per sopravvivere soltanto – e altri che resistono, invece, altri che si affidano alle tavole delle “bonae artes”, altri che mettono mano alla costruzione di “naviculae”. E nessuno più di questi è caro agli dei: nessuno più di coloro che lottano per guidare le nostre navicelle e per riparare queste tavole.
E ci direbbe Manfredo che questo è “improbus labor”, un lavoro così faticoso da apparire iniquo: costruire andando, costruire nel tempo, costruire col tempo concessoci. “Niuna cosa si trova più faticosa del vivere e occorre affrontarla con le mani e coi piedi, con tutti i nervi, con ogni industria e consiglio”. Non basta la ragione, non basta l’esperienza, occorrono mani e piedi e nervi per ritrarre e ritenere incessantemente le vele in tutte le tempeste, in ogni fortuna e in ogni naufragio. “Improbus labor”, senza spettatori, che non ammette spettatori. Nessuno è libero dalla vicissitudo che tutti ci costringe, che tutti siamo. E tale vicissitudine obbliga al contrario esercizio, alla perenne trasformazione, al sapere per indizi e congetture.
Di tale sapere è stato maestro Manfredo – non di fondamenti o certezze.
Ma lo ha insegnato senza enfasi, senza retorica alcuna. Con ironia lo affermava, e perciò con tanto più vigore: poiché ironia significa insistenza dell’interrogare, e distacco e misura del pathos. Manfredo insegnava che la stessa virtù, lo stesso esercizio hanno la medesima radice dell’impazienza e dell’irrequietezza che ci affliggono, che la stessa ricerca e la stessa interrogazione manifestano i principi di quell’attesa, di quell’ansia, di quella incontentezza da cui vorremmo pure liberarci. Manfredo insegnava che il nostro essere vicissitudine equivale alla necessità di mascherarci, di contraffarci, di denaturare tutto. Insegnava Manfredo che la forza che ci rinnova e ci sospinge è quella stessa che ci trascina. Insegnava la cosa più difficile: l’arte del disincanto insieme a speranza e fede. E’ facile il disincanto che sopraggiunge alla morte di speranza e fede; ed è altrettanto facile comunicare speranza e fede quando non si è appreso o si rifiuta l’aspro esercizio del disincanto. Ma insegnare disincanto, speranza e fede in uno, insegnare quella fede e quella speranza che esigono disincanto, e quel disincanto che ci tiene sgombro lo sguardo per vedere speranza e fede – ebbene, di questo sono capaci soltanto i maestri più grandi, qualsiasi sia la loro disciplina.
L’ultimo, grande libro di Manfredo si intitola “ricerca del Rinascimento”. E’ ben più di una ricerca sul Rinascimento: è la visione del Rinascimento come ricerca. Questo titolo è già in se un programma di filologia come amore per la parola viva, per il classico come ciò che sempre ci interroga e ci mette in questione, per il classico come cardine delle nostre stesse inquietudini.
Ebbene, Manfredo volle che sulla copertina di questo suo libro comparisse l’emblema del nostro amico carissimo – del maestro che ha segnato negli ultimi anni la nostra amicizia, Leon Battista Alberti – inciso da Matteo de’ Pasti. In esso egli vedeva, di nuovo insieme, la velocità del colpo d’occhio, dell’intuizione e la fatica che costa l’essere sempre desti, “per vigili et circumspecti”, il non poter mai essere in pace. Rapido, sì, alato il nostro occhio, ma niente affatto divino, è lo sguardo fisso alla domanda scolpita sotto la sua immagine: “quid tum”. Che cosa allora? Che cosa, quando siamo giunti ad essere così vigili, così “circumspecti”? Che cosa vediamo, allora, amici filologi, amici filosofi? Forse che il vostro edificio cessa di essere maschera? Che cosa avete trovato nella vostra veglia interminabile? “Fruga fino al limite estremo, sconvolgi pure le montagne, scandaglia il fondo dei fiumi e dei mari, porta alla luce quello che è nascosto- ma il luogo della sapienza dov’è? Sapientia vero ubi invenitur?” Chi non sente la domanda dei Salmi al termine di ogni pagina, di ogni riga, di ogni parola di Manfredo, nulla ha compreso della sua opera.
In ciò consiste la sua profonda religiosità: vera non saeva religio, quella che libera alla domanda, all’attesa – quella del Deus semper adveniens, non del dio che è stato. Religiosità che sta alla radice dell’anti-dogmatismo di Manfredo, del suo costante corpo a corpo contro tutti i dogmatismi. Chi è più vecchio tra noi lo ricorda, tra anni ’60 e ’70, con quanta sferzante ironia criticasse i dogmatismi allora imperanti. quelli della Novitas, dell’Avantgarde – e proprio attraverso il richiamo alla filologia, alla pietas per la tradizione viva. Ma ancor più aspra è stata la sua polemica contro i dogmatismi attuali, contro quell’odioso dogmatismo che si ammanta di relativismo e convenzionalismo, che chiacchiera ad ogni piè sospinto di “morte dell’ideologia”, e per il quale, in realtà, tutto è relativo fuorché appunto il relativo, tutto è scambiabile fuorché appunto che tutto sia scambiabile, merce, prodotto, moda.
Di questa critica animava le sue lezioni e i suoi libri e i suoi incontri con tutti noi – di questa etica della convinzione che è infinitamente più profonda di una semplice etica della responsabilità.
In questa città, che proprio Manfredo ci ha insegnato a capire e ad amare, lui che non era di questa città, come luogo di tempi plurali, come forza di una “renovatio” senza catastrofi, scevra da gesti, parole, frasi, ricca delle sue dissonanze – in questa città sapremo rimanergli fedeli? Sapremo continuare ad ascoltare il suo sereno-severo richiamo alla cosa, il suo “de re aedificatoria”? poiché noi costruiamo nel tempo e di tempo son fatti i nostri edifici. E del tempo, dunque, dobbiamo imparare a fare tesoro – per poterne sempre avere, così come Manfredo sempre ne aveva, per i suoi amici, per i suoi allievi, per i suoi concittadini. Era il suo tempo, Manfredo, e mai è stato del tempo.
Sapremo anche noi fare del tempo concessoci opera, costruzione, pittura, lineamento, misura?
E’ difficile oggi pensare che ce la faremo, senza la sua presenza, senza il suo esempio. E’ facile pensare, invece, che finiremo sommersi nel diluvio di chiacchiere, di rumori, di dogmatismi alla moda, i più opposti ad ogni convinzione e ad ogni responsabilità. Eppure, dobbiamo prometterlo, oggi, dobbiamo promettercelo, qui, intorno a Manfredo: cercheremo “con le mani e coi piedi, con tutti i nervi, con ogni industria e consiglio” di essergli fedeli, di ascoltarlo.
Ne va non solo della nostra scuola, non solo del rapporto tra noi, tra studenti, docenti e non docenti di questa scuola – ne va, vorrei dire se non temessi di cadere in quella retorica che Manfredo aborriva, ne va della nostra anima.